Alan Mattiassi si definisce uno psicologo del gioco, un’etichetta che non corrisponde a un titolo ufficiale né a un albo professionale, ma che descrive in modo diretto il suo campo di attività.
Il ruolo del gioco e lo stigma in Italia
La sua formazione è quella di uno psicologo, ma il suo lavoro non si svolge in ambito clinico o sanitario. Si concentra invece sulla progettazione che pone il gioco al centro, occupandosi dell’intersezione fra dinamiche ludiche e processi mentali e cognitivi, per comprendere come ciò che avviene nella mente si traduca in comportamento. Mattiassi sottolinea come la psicologia del gioco non sia ancora riconosciuta come disciplina accademica autonoma, pur essendo da tempo oggetto di riflessione teorica da parte di autori come Piaget, che vedeva nel gioco un mezzo di transizione da uno stadio di sviluppo all’altro. Nonostante l’assenza di corsi universitari dedicati, ritiene che i tempi siano maturi perché il gioco venga trattato in modo organico all’interno della formazione psicologica.
Parlando del contesto culturale, osserva che in Italia il gioco ha sofferto a lungo uno stigma legato alla contrapposizione con il lavoro. Per decenni il riferimento principale al gioco da tavolo è stato rappresentato da Monopoli e Risiko, titoli che implicavano esperienze frustranti: lunghi tempi di attesa, scarse possibilità di vittoria, eliminazioni precoci. Questo approccio ha contribuito a diffondere una visione del gioco come attività poco gratificante. In parallelo, però, gli anziani hanno sempre mantenuto spazi di gioco legittimati socialmente, come la tombola o le carte, mostrando che l’attività ludica soddisfa bisogni profondi e ritorna in fasi diverse della vita.
Con l’avvento delle nuove tecnologie e di console che hanno aperto l’esperienza ludica a tutta la famiglia, la percezione del gioco è cambiata. In ambito accademico, Mattiassi rimarca che il gioco porta le persone al limite delle loro capacità: gli scacchi, ad esempio, costringono a confrontarsi con i propri limiti cognitivi, stimolando la memoria e l’elaborazione strategica, mentre i videogiochi richiedono precisione, prontezza e coordinazione. Questo ribalta l’idea che giocare sia solo una perdita di tempo: al contrario, mentre si gioca si mettono in atto abilità cognitive, motorie e sociali.
Dal punto di vista psicologico, il gioco non solo mantiene attivo il cervello ma rappresenta anche un fattore protettivo per l’invecchiamento. Le dinamiche sociali che si sviluppano attorno ai giochi di società contribuiscono a rallentare il decadimento cognitivo, favorendo il benessere nelle età più avanzate.
Giocare mantiene il cervello allenato: è una constatazione che vale dagli anziani ai più giovani. Negli adulti e negli anziani, il gioco stimola le capacità cognitive, mentre nei bambini e nei ragazzi l’impatto è visibile sulle abilità di apprendimento, anche se limitato e dipendente da condizioni specifiche. I videogiochi, in particolare, possono migliorare alcune competenze cognitive, sempre all’interno di contesti studiati e controllati. Questi dati non devono essere decontestualizzati: ogni risultato va discusso e analizzato con attenzione, ma la letteratura scientifica fornisce evidenze solide.
Oltre all’aspetto cognitivo, il gioco ha effetti sul benessere generale. Durante la pandemia da Covid-19, ad esempio, molte persone hanno continuato a giocare pur in isolamento: chi ha trovato il modo di farlo ha mantenuto livelli di benessere più alti rispetto a chi non ha avuto questa possibilità. Si tratta di un esperimento naturale che, seppur nato da circostanze difficili, conferma il potenziale benefico del gioco. Anche i self-report, cioè i racconti diretti dei giocatori, confermano effetti positivi su diversi ambiti della vita quotidiana: socializzazione, gestione dello stress, e soddisfazione personale.
Nonostante questi dati, il gioco rimane spesso stigmatizzato negli adulti. L’attività fisica, per esempio, non suscita dubbi: sappiamo tutti che correre, nuotare o giocare a calcio fa bene. Ma se parliamo di giochi di ruolo o videogame per adulti, l’opinione comune fatica a riconoscerne il valore. Anche oggi, il videogioco è visto da molti come una “perdita di tempo” o addirittura come un comportamento potenzialmente dannoso, un retaggio di stereotipi che persistono da generazioni. Puntate di serie o episodi satirici hanno cristallizzato immagini negative: pensiamo al classico adulto obeso e disordinato davanti al computer, un cliché ancora presente nell’immaginario collettivo.
La radice di questo atteggiamento è la paura dell’ignoto: non comprendere cosa accade nella mente del giocatore porta a giudizi superficiali. La differenza tra osservare un comportamento fisico e comprendere uno stato mentale è enorme. Nei videogiochi, così come in altri contesti ludici, si attiva spesso uno stato di concentrazione totale, simile a quello degli atleti o degli artisti, che chi conosce il fenomeno definisce “flow”.
Il flow, concetto sviluppato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, è uno stato di esperienza ottimale: ci si concentra completamente sull’attività, con feedback immediati, obiettivi chiari e sfide calibrate al limite delle proprie capacità. Non è né troppo facile né impossibile, ma sufficientemente stimolante da catturare l’attenzione e motivare l’azione. Questo equilibrio genera soddisfazione, senso di controllo e persino miglioramento delle capacità cognitive, sociali ed emotive.
Storicamente, l’ignoranza sui giochi ha generato panico morale: dagli anni Ottanta e Novanta si accusava chi giocava a giochi di ruolo di comportamenti satanisti, oggi invece la tolleranza è maggiore, ma la comprensione resta limitata. Non tutti sanno distinguere tra i diversi tipi di videogame: giocare a Fortnite è diverso da giocare a Minecraft, e ognuno stimola abilità diverse. Ciò che invece è chiaro è che il gioco, anche digitale, è uno strumento potente per allenare il cervello, stimolare la creatività, migliorare il ragionamento critico e favorire la socializzazione.
In confronto a 30 anni fa, quando i ragazzi trascorrevano ore davanti a TV prive di contenuti, tra cartoni, pubblicità e televendite, l’attività ludica moderna è molto più attiva e stimolante. Il tempo dedicato al gioco non è più passività, ma un allenamento cognitivo che, se gestito correttamente, produce benefici concreti.
In sostanza, il gioco non è solo intrattenimento: è un contesto in cui si allenano mente e emozioni, si sviluppano capacità sociali e si sperimenta il flow, uno stato che rende la vita più piena e coinvolgente. Riconoscere questo valore significa superare vecchi pregiudizi e comprendere quanto possa essere importante anche nella vita degli adulti.
Quale è il ruolo del flow nel benessere trasmesso dal gioco?
Il concetto di flow, o stato di flusso, si basa su un principio semplice ma potente: l’equilibrio tra la sfida che ci viene proposta e le nostre abilità. Possiamo entrare in flow sia da principianti, quando percepiamo di poter raggiungere un obiettivo anche se la sfida è bassa, sia da campioni del mondo, quando la sfida è massima e alla nostra altezza. Nei giochi, questo equilibrio è facilmente gestibile: si può modulare la difficoltà del gioco stesso oppure giocare con persone del nostro stesso livello. In entrambi i casi, il risultato è una perfetta immersione nell’attività, dove il tempo sembra fermarsi e la concentrazione diventa totale.
Lo stato di flow ha effetti profondi sul benessere e sulla performance. Non è tanto questione di “produttività”, ma di efficacia: mentre siamo immersi in un’attività che ci stimola, tutto il resto del mondo scompare, e questo genera una condizione unica di concentrazione e soddisfazione. Questo distacco può spaventare chi osserva da fuori, perché non comprende cosa stia succedendo: il giocatore sembra scollegato dalla realtà, ma in realtà sta vivendo un’esperienza intensa e pienamente coinvolgente.
Film come Soul della Pixar hanno rappresentato perfettamente questo concetto: il protagonista entra in una “bolla” di totale immersione, coltivando la propria passione senza perdere di vista, almeno idealmente, i limiti legati al benessere e alle relazioni. Tuttavia, la società tende ancora a stigmatizzare il gioco: viene considerato una perdita di tempo, un’attività per bambini, mentre il lavoro retribuito è visto come “utile”. Questo pregiudizio limita la possibilità di dedicarsi al flow attraverso il gioco, pur quando questo sarebbe la vera fonte di soddisfazione e apprendimento.
Il gioco come palestra cognitiva
Dal punto di vista evoluzionistico, il gioco ha una funzione chiara: è un ambiente sicuro in cui sperimentare e accumulare conoscenze che saranno utili nella vita reale. Un animale che gioca alla caccia, per esempio, non cattura la preda ma impara strategie, affinando abilità che potranno salvarlo in futuro. Chi non gioca perde l’opportunità di esplorare alternative e rischia di essere svantaggiato. Allo stesso modo, negli esseri umani il gioco sviluppa competenze cognitive, sociali e creative, fornendo strumenti utili anche nella vita adulta.
Un esempio emblematico è quello del creatore di Minecraft: il successo economico e la ricchezza non hanno portato la stessa soddisfazione del processo creativo, della costruzione e della sperimentazione dentro il gioco. Il vero benessere per lui era il flow generato dall’attività stessa, non i miliardi accumulati. Questo dimostra quanto sia personale e specifico il concetto di “scintilla vitale”: ciò che per qualcuno rappresenta il successo, per un altro può essere solo un mezzo, non il fine.
Applicazioni del gioco in azienda
Il potenziale del gioco può essere sfruttato in diversi contesti aziendali, con effetti concreti sulla formazione, la motivazione e l’organizzazione interna. Possiamo distinguere tre livelli principali:
- Formazione aziendale
La formazione tradizionale spesso risulta noiosa e poco efficace. Integrare elementi ludici permette di creare esperienze coinvolgenti, dove i concetti vengono assimilati attraverso l’emozione e l’elaborazione attiva, aumentando la comprensione e la memorizzazione. Strumenti come i Lego Serious Play dimostrano come la dimensione ludica possa attivare il pensiero critico e la creatività in maniera naturale, trasformando una giornata formativa in un’esperienza concreta e memorabile. - Gamification
La gamification consiste nell’applicare elementi tipici dei giochi ad attività non ludiche, rendendo operazioni quotidiane più motivanti. Un esempio classico è l’“impiegato del mese”, un sistema che stimola competizione e partecipazione senza ripercussioni dirette. La differenza tra gioco e gamification è che nel primo possiamo esplorare senza rischi, mentre nella seconda le azioni hanno conseguenze reali. L’obiettivo è motivare e facilitare la collaborazione, la creatività e l’efficienza. - Comprensione e ottimizzazione dei processi
Pensare a un’azienda come a un gioco permette di identificare condizioni di vittoria, nodi critici e colli di bottiglia. Creare simulazioni ludiche delle dinamiche aziendali consente ai dipendenti di comprendere le interazioni complesse tra reparti e obiettivi, facilitando decisioni più consapevoli. Esempi concreti includono giochi da tavolo virtuali che mappano processi reali, o interventi in contesti sanitari, come giochi per bambini che li aiutano a restare fermi durante le scansioni mediche, ottimizzando il workflow del reparto senza ricorrere all’anestesia.
Consigli pratici su come utilizzare il gioco in azienda
Per integrare il gioco in azienda serve prima di tutto superare lo stigma. Il gioco non è una perdita di tempo, ma un potente strumento cognitivo e motivazionale. Serve inoltre una progettazione esperta: improvvisare giochi in-house rischia di produrre risultati nulli o addirittura controproducenti. Le dinamiche ludiche vanno studiate, create e valutate, con attenzione all’effetto reale sul comportamento e sull’apprendimento.
In sintesi, per trarre vantaggio dal gioco in azienda è necessario:
- riconoscere il valore del flow e dell’immersione,
- progettare attività con obiettivi chiari e feedback immediati,
- coinvolgere esperti nella progettazione e nella valutazione,
- superare pregiudizi e approcci superficiali.
Chi comprende queste dinamiche può trasformare il gioco in un alleato strategico, migliorando formazione, efficienza e benessere dei dipendenti, e scoprendo potenzialità spesso ignorate nei metodi tradizionali.











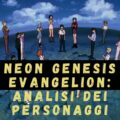


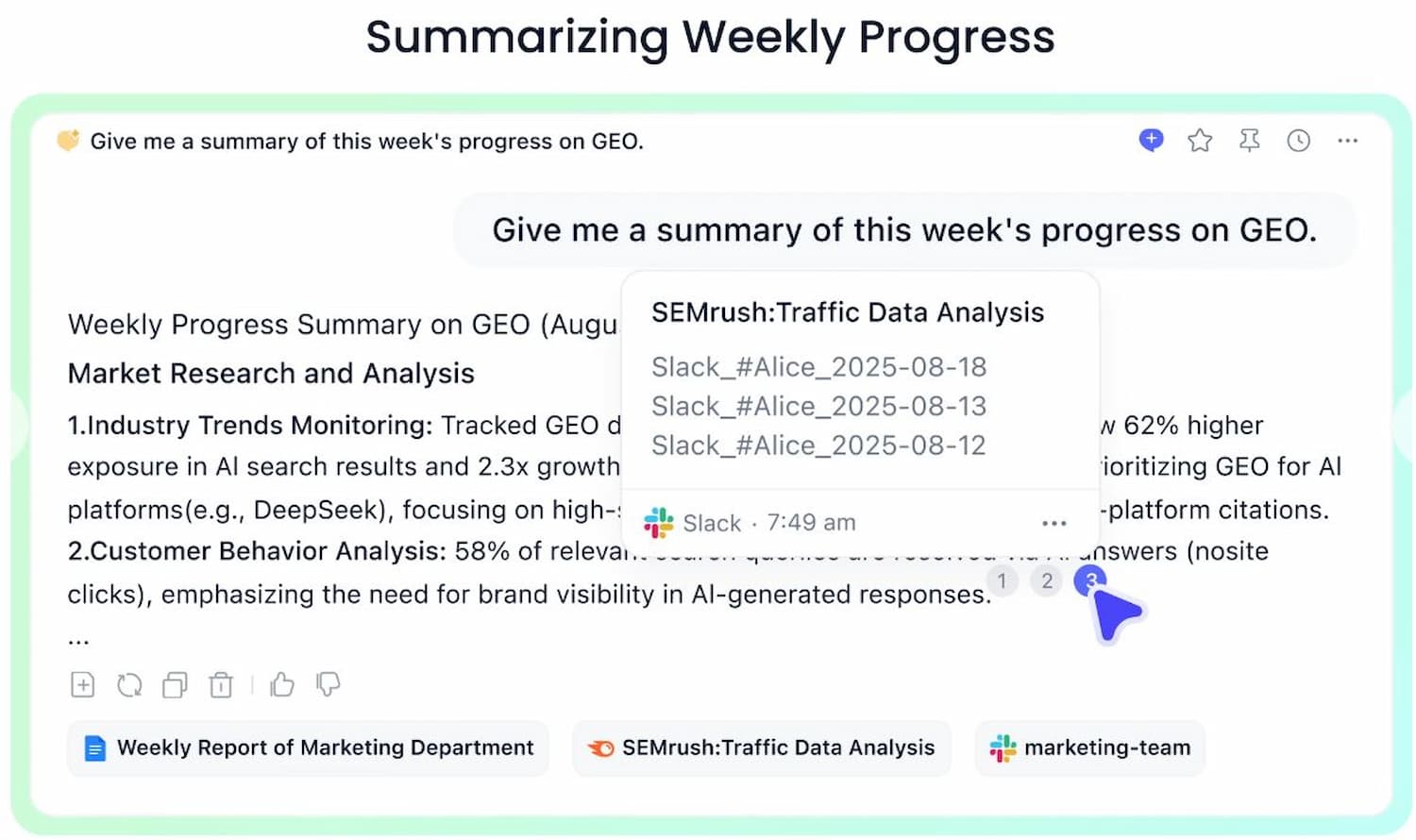



























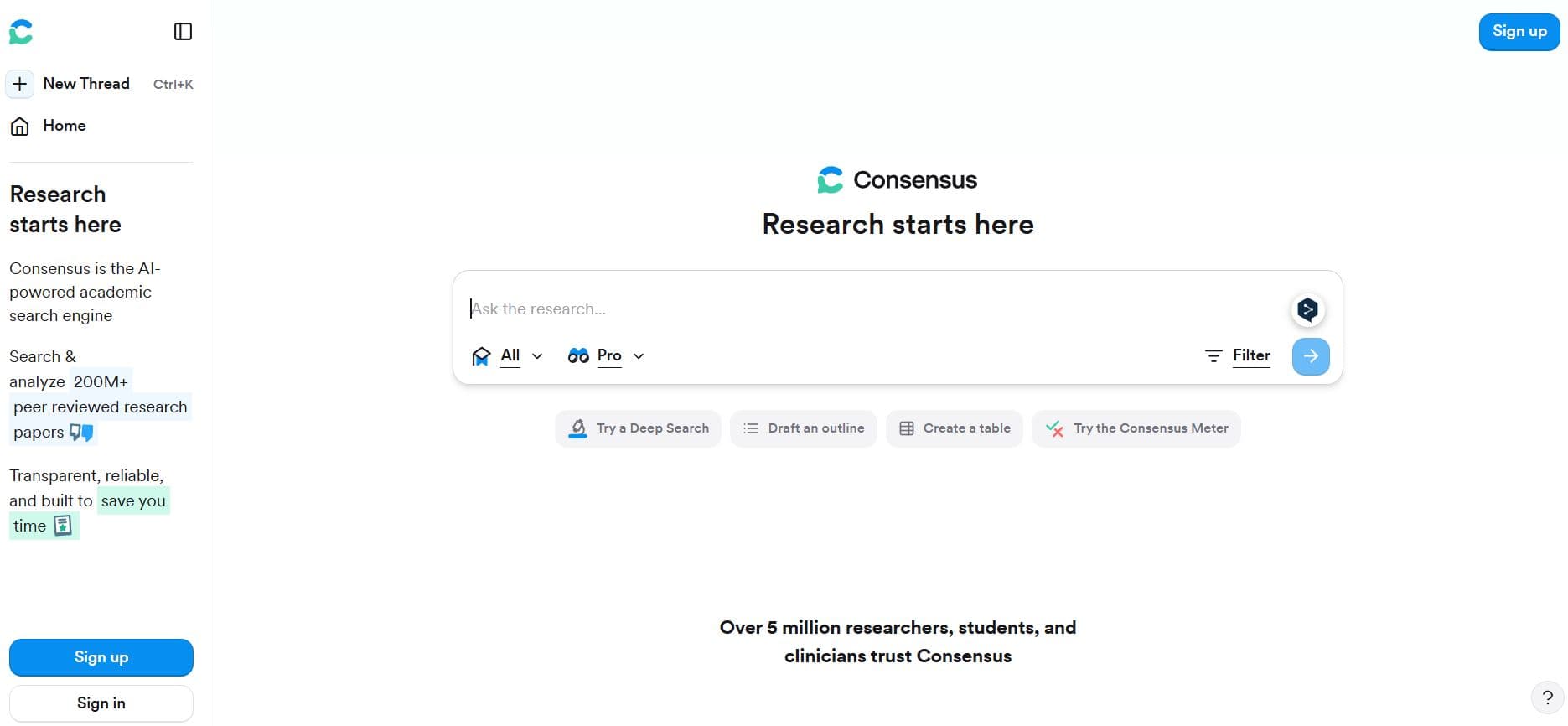
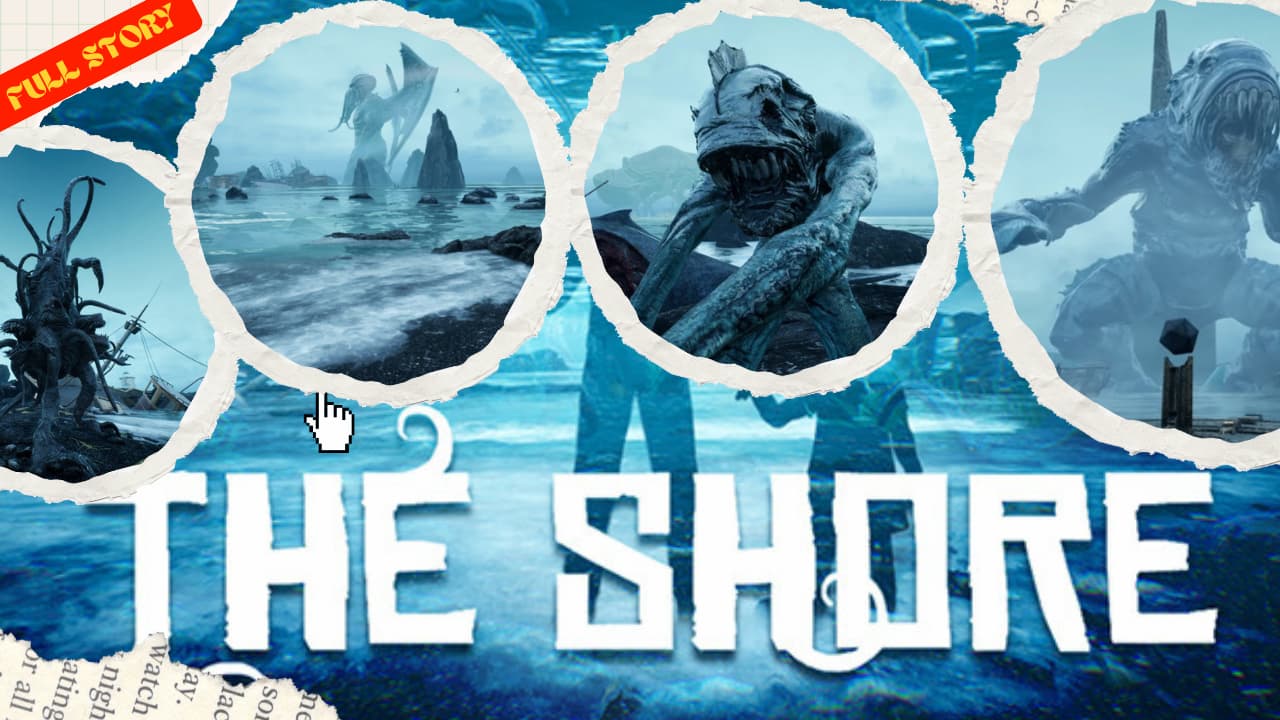



Leave a Reply