Ci sono momenti che non ci lasciano più. Non importa quanto tempo sia passato, quante volte abbiamo rivisto quelle scene. Alcuni dolori cinematografici sono così intensi che ci restano dentro per sempre. E gli anni ’80 e ’90 non avevano paura di farci soffrire. Anzi, sembravano volerci preparare – bruscamente – alla vita.
Oggi ripercorriamo cinque scene strazianti, incise nell’infanzia di chi è cresciuto in quell’epoca. Scene che ci hanno insegnato che il cuore si può spezzare anche davanti a un cartone animato.
[5 – LA MORTE DELLA SCARPA – CHI HA INCASTRATO ROGER RABBIT (1988)]
Era il 1988 quando Robert Zemeckis ci portò in un mondo dove cartoon e umani coesistevano. “Chi ha incastrato Roger Rabbit” prometteva di essere un’avventura brillante, piena di gag e personaggi indimenticabili. E lo era… finché non arrivava lui.
Il Giudice Doom. Christopher Lloyd nei panni dell’incubo di Cartoonia. Un personaggio che ci ha insegnato cosa significa il male. Quello vero, quello che non fa sconti.
Una scarpa. Non un personaggio principale. Non un eroe. Solo una piccola scarpa animata. Indifesa. Innocente. Guardate i suoi occhi. Vedete come vibra di vita, gli occhioni spalancati, come si muove con quella delicatezza? Doom la accarezza, quasi con tenerezza. La tiene in mano come si farebbe con un piccolo animale. E poi…
L’urlo di quella scarpa che si dissolve lentamente nella salamoia è uno dei suoni più strazianti mai sentiti in un film per famiglie. È morte. È dolore puro.
Gli animatori e il sound designer hanno creato qualcosa di indimenticabile: la rappresentazione della violenza gratuita, sadica. La morte che arriva senza ragione, senza giustizia. E l’hanno fatto in un film che doveva essere divertente.
Richard Williams, il genio dell’animazione dietro il film, ha dichiarato anni dopo che questa scena aveva un doppio scopo: stabilire Doom come villain senza redenzione, ma anche ricordarci che dietro il divertimento dei cartoon c’è sempre stato un elemento di crudeltà che da adulti tendiamo a dimenticare.
[4 – LA MORTE DELLA MAMMA DI PIEDINO – ALLA RICERCA DELLA VALLE INCANTATA (1988)]
Era il 1988 quando Don Bluth, ex-animatore Disney, decise di spezzarci il cuore con “Alla Ricerca della Valle Incantata”. Un film d’animazione sulla preistoria, sui dinosauri, sulla grande migrazione. Un film per bambini, ci dicevano.
Ma Bluth sapeva quello che stava facendo. Sapeva che i bambini non hanno bisogno di essere protetti dalla verità. E la verità è che la vita è anche dolore. È anche perdita. È anche solitudine.
Un temporale apocalittico. Un terremoto che divide la terra. Un feroce predatore che emerge dall’oscurità. Una sequenza di eventi catastrofici che cambieranno per sempre la vita di un piccolo dinosauro.
La madre di Piedino si erge contro la natura stessa. Si batte con tutta la sua forza contro un tirannosauro implacabile, contro il caos di un mondo che si sta letteralmente spaccando in due. È una delle sequenze d’azione più intense mai animate, ma sotto c’è molto di più. C’è l’amore disperato di una madre. C’è il sacrificio ultimo.
Ferita a morte, crolla a terra. Piedino la chiama, la implora. E la voce di Helen Shaver, che doppiava la madre, trova quel perfetto equilibrio tra forza e fragilità.
“Io sarò sempre con te, anche se non puoi vedermi.”
Gli sorride, gli indica la strada, gli dice che sarà forte. E poi chiude gli occhi. Per sempre.
Ciò che rende questa sequenza ancora più straziante è ciò che segue. Piedino torna da lei nei giorni successivi. La cerca, non capisce. Vede un’ombra e crede sia lei. Rincorre un miraggio attraverso il deserto. E poi, finalmente, comprende. James Horner, compositore della colonna sonora, crea in questo momento una delle melodie più struggenti mai scritte per un film d’animazione. Poche note di pianoforte che accompagnano la più pura rappresentazione del dolore infantile.
Piedino crolla. Piange da solo, abbandonato in un mondo ostile. Non c’è nulla di edulcorato, nulla di attenuato. È puro, devastante dolore.
Per tanti di noi, seduti in quelle sale buie del 1988, è stata la prima volta che abbiamo visto morire una madre sullo schermo. La prima volta che abbiamo capito che la sicurezza può svanire in un istante. È stato il nostro primo incontro con la morte, con il lutto, con l’assenza irrimediabile.
Don Bluth ha dichiarato anni dopo: “I bambini possono sopportare qualsiasi cosa, purché abbia un lieto fine.” Ma ciò che non disse è che quel “lieto fine” arriva a un prezzo altissimo. Piedino sopravvive, trova nuovi amici, raggiunge la Valle Incantata. Ma non sarà mai più lo stesso.
[3 – LA MORTE DI MUFASA – IL RE LEONE (1994)]
Il 1994 segnò un momento cruciale nella storia dell’animazione. La Disney, all’apice della sua rinascita creativa, decise di raccontare una storia shakespeariana nella savana africana. “Il Re Leone” era destinato a diventare un classico, ma nessuno poteva prevedere quanto profondamente avrebbe segnato un’intera generazione.
La sequenza della morte di Mufasa è diventata l’emblema del trauma infantile cinematografico. Una maestria narrativa che collega tradimento familiare, innocenza spezzata e l’implacabile ciclo della vita.
Mufasa, doppiato magnificamente dal possente James Earl Jones, non è solo un re. È l’incarnazione della nobiltà, della saggezza, della protezione paterna. Quando salva il piccolo Simba, non sta solo compiendo un atto eroico. Sta definendo cosa significhi essere padre.
Il tradimento arriva con una frase sussurrata che risuona come tuono: “Lunga vita al re“. Scar, con la voce vellutata e velenosa di Jeremy Irons, non si limita a uccidere il fratello. Lo condanna con l’ironia più crudele. La caduta di Mufasa è filmata in slow motion, una tecnica che la Disney aveva raramente utilizzato prima, amplificando l’orrore del momento.
Ma è ciò che accade dopo che ha lasciato cicatrici emotive nei cuori di milioni di spettatori.
Simba, piccolo, confuso, trova il corpo del padre nella polvere della gola. La musica di Hans Zimmer si fa sottile, quasi impercettibile. Il mondo intorno sembra dissolversi. La macchina da presa si allontana, rispettosa del dolore intimo di un figlio.
“Papà? Devi alzarti.” La voce rotta di Jonathan Taylor Thomas, che doppiava il giovane Simba, trasmette una vulnerabilità che trascende l’animazione. Non c’è consapevolezza della morte, solo incomprensione, negazione. “Dobbiamo tornare a casa.”
Il compositore Hans Zimmer ha rivelato che per questa scena si ispirò alla musica funebre africana, creando una melodia che risuona di ancestrale dolore collettivo.
Simba scuote il padre, lo spinge, cerca disperatamente di risvegliarlo. Ogni tentativo fallito è una pugnalata per lo spettatore. Non c’è sangue, non c’è violenza esplicita. C’è solo il silenzio della morte che incontra l’innocenza dell’infanzia.
E poi, quel momento straziante: Simba si accuccia sotto la zampa di Mufasa, cercando per l’ultima volta quel calore protettivo. Si sdraia accanto a lui, sperando che, se resta lì abbastanza a lungo, tutto tornerà com’era.
In quel silenzio c’è l’inizio della perdita. Del senso di colpa manipolato da Scar. Del trauma che segnerà Simba negli anni dell’esilio. Il piccolo leone non comprende ancora che sta dicendo addio, prima ancora di saper pronunciare quella parola.
Gli animatori della Disney studiarono il comportamento dei leoni in lutto per rendere autentica la reazione di Simba. Notarono come i cuccioli spesso non si allontanano dai corpi dei genitori defunti, rifiutandosi di accettare la realtà.
Quando Simba urla “Aiuto! Qualcuno! Chiunque!”, non è solo un grido di disperazione. È il momento in cui ogni bambino in sala ha compreso, forse per la prima volta, che ci sono dolori da cui nemmeno i genitori possono proteggerci.
[2 – LA MORTE DELLA MAMMA DI BAMBI – BAMBI (1942), riproposto negli anni ‘80 e ‘90
L’America è nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Walt Disney decide di adattare il romanzo di Felix Salten, “Bambi, la vita di un capriolo”. Una scelta audace, in un momento in cui il pubblico cercava evasione. Ma Disney sapeva qualcosa che altri ignoravano: a volte, per toccare davvero il cuore, devi prima spezzarlo.
La sequenza della morte della madre di Bambi è diventata il metro di paragone di ogni trauma cinematografico. Ottant’anni dopo, continua a essere il riferimento culturale per eccellenza quando si parla di perdita nell’infanzia.
Un prato innevato, la neve che cade lieve. Il bianco, colore dell’innocenza, diventa il palcoscenico per il primo grande dolore. Bambi e sua madre stanno cercando cibo nell’inverno rigido. Lei sente qualcosa. Si tende. I suoi occhi si allargano.
Frank Thomas, uno dei “Nine Old Men” di Disney, gli animatori leggendari dello studio, ha raccontato che per questa scena studiò il comportamento dei cervi per settimane. Voleva catturare quel momento preciso in cui un cervo percepisce il pericolo – quella frazione di secondo in cui ogni muscolo si irrigidisce prima della fuga.
“Corri, Bambi!” La voce di Paula Winslowe, che doppiava la madre, contiene tutto: l’urgenza, la paura, l’amore protettivo. Tre parole che racchiudono l’essenza stessa della maternità. La volontà di sacrificarsi per il proprio figlio.
Si sente uno sparo. Secco, brutale. Non vediamo l’uomo. Non ne abbiamo bisogno. È il primo antagonista realmente terrificante della Disney, proprio perché resta invisibile.
Bambi corre. Corre come le ha sempre insegnato sua madre in una scena precedente del film. Corre con la certezza infantile che lei sarà dietro di lui. Che lo raggiungerà, come ha sempre fatto.
La musica di Frank Churchill e Edward Plumb si fa improvvisamente rarefatta. Quasi scompare, lasciando solo il suono del vento e dei passi di Bambi nella neve.
Walt Disney prese una decisione rivoluzionaria: non mostrare la morte. Non mostrare il corpo. Non mostrare sangue. Aveva capito che l’orrore più profondo risiede nell’immaginazione, nel non detto, nell’assenza.
Bambi si ferma. Si gira. E lei non c’è più.
La voce del piccolo Bambi, doppiato da Bobby Stewart, trasmette una confusione che trascende le specie. È la voce universale del bambino che non comprende l’irrevocabilità della morte.
I censori dell’epoca protestarono veementemente. Troppo traumatico, dissero. Walt Disney rispose: “La vita è fatta di luce e ombra. Non possiamo proteggere i bambini dalla verità, ma possiamo aiutarli ad affrontarla.”
La macchina da presa si allontana, mostrando la vastità della foresta innevata. Bambi è un puntino minuscolo in un mondo improvvisamente troppo grande. La solitudine non è mai stata rappresentata con tale potenza visiva. È uno dei momenti più traumatici della storia dell’animazione. Perché ci fa sentire davvero soli. Perché non offre spiegazioni, né redenzione immediata. Solo perdita. Un’assenza che echeggia. Una ferita che non si rimargina.
Ottant’anni dopo, quella scena rimane impressa nella memoria collettiva. Perché in quel prato innevato, nel silenzio di quella foresta, abbiamo tutti perso qualcosa. L’innocenza. La sicurezza. La convinzione che i genitori siano immortali.
[1 – LA MORTE DEL CAVALLO ARTAX – LA STORIA INFINITA (1984)]
Il regista tedesco Wolfgang Petersen, fresco del successo internazionale di “U-Boot 96”, si cimenta con un’impresa titanica: adattare il romanzo fantasy di Michael Ende, “La Storia Infinita”. Un film dove la fantasia è letteralmente salvifica, dove l’immaginazione è l’arma più potente.
Eppure, in questo inno alla creatività e alla speranza, si nasconde una delle sequenze più nichiliste e spietate mai inserite in un film per ragazzi.
Le Paludi della Tristezza. Un nome che è già una condanna. Un luogo dove non esistono mostri tangibili, creature con zanne o artigli. Qui il nemico è invisibile, insidioso. È dentro. È la disperazione che si fa paesaggio.
Quando Artax, il cavallo bianco di Atreiu, smette improvvisamente di camminare, non è per stanchezza fisica. Non è per un ostacolo sul cammino. È perché la tristezza lo ha svuotato dall’interno. Un concetto metafisico, astratto, reso viscerale e tangibile attraverso un’immagine di devastante semplicità: un cavallo che si arrende.
Klaus Doldinger, compositore della colonna sonora, fa una scelta rivoluzionaria: il silenzio. Nessuna musica drammatica accompagna la scena. Solo il suono del fango che risucchia, dell’acqua che gorgoglia. E la voce di Atreyu.
Noah Hathaway, l’attore che interpretava Atreyu, ha confessato anni dopo che questa scena lo traumatizzò così profondamente che evitò di riguardare il film per decenni. A soli 12 anni, dovette attingere a un dolore autentico per interpretare quel momento. “Devi lottare contro la tristezza!” grida al suo amico. “Artax, ti prego!”
La sua voce si incrina, si spezza. Non è recitazione. Sono lacrime vere quelle che scorrono sul volto del giovane attore. Petersen ha rivelato che girarono la scena una sola volta. Era troppo straziante chiedere al ragazzo di ripeterla.
Il cavallo Artax – interpretato da un magnifico stallone bianco andaluso di nome Artax nella vita reale – venne addestrato per mesi a immergersi gradualmente in una vasca speciale. Una piattaforma idraulica lo abbassava lentamente, mentre effetti speciali meccanici (erano gli anni ’80, ben prima del CGI) creavano l’illusione del fango che lo inghiottiva.
La scena è di una crudezza sconvolgente proprio perché rifiuta ogni consolazione. Non c’è musica epica, non c’è salvezza dell’ultimo secondo. Non c’è un dio o un eroe che interviene. C’è solo impotenza, angoscia e una perdita profondamente ingiusta.
Per noi, bambini degli anni ’80, seduti nei cinema o davanti ai primi videoregistratori, è stata una lezione spietata e inaspettata: la tristezza può uccidere. E a volte, nonostante tutto l’amore e la disperazione, non possiamo fare nulla per impedirlo.
E da quel momento, per una generazione intera, niente è stato più solo un’avventura. Abbiamo imparato che anche nelle storie più fantastiche si nasconde una verità dolorosa. Che a volte il fango della tristezza può reclamare ciò che amiamo,
Tutti questi momenti ci hanno ferito. Ci hanno fatto piangere, a volte in silenzio, a volte in pubblico. Eppure li ricordiamo. Hanno fatto ciò che l’infanzia non dovrebbe fare, ma che a volte è necessario: ci hanno insegnato il dolore. E ci hanno reso più umani.
Ogni volta che rivediamo quelle scene, riviviamo qualcosa di profondo. Una parte di noi rimasta lì, in quell’attimo. Perché anche attraverso le lacrime, abbiamo imparato a sentire. E forse, proprio per questo, non le dimenticheremo mai.
Ma è giunto il momento di asciugarci le lacrime. Scrivete nei commenti quale è la vostra scena preferita e perché vi ha fatto piangere!











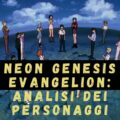
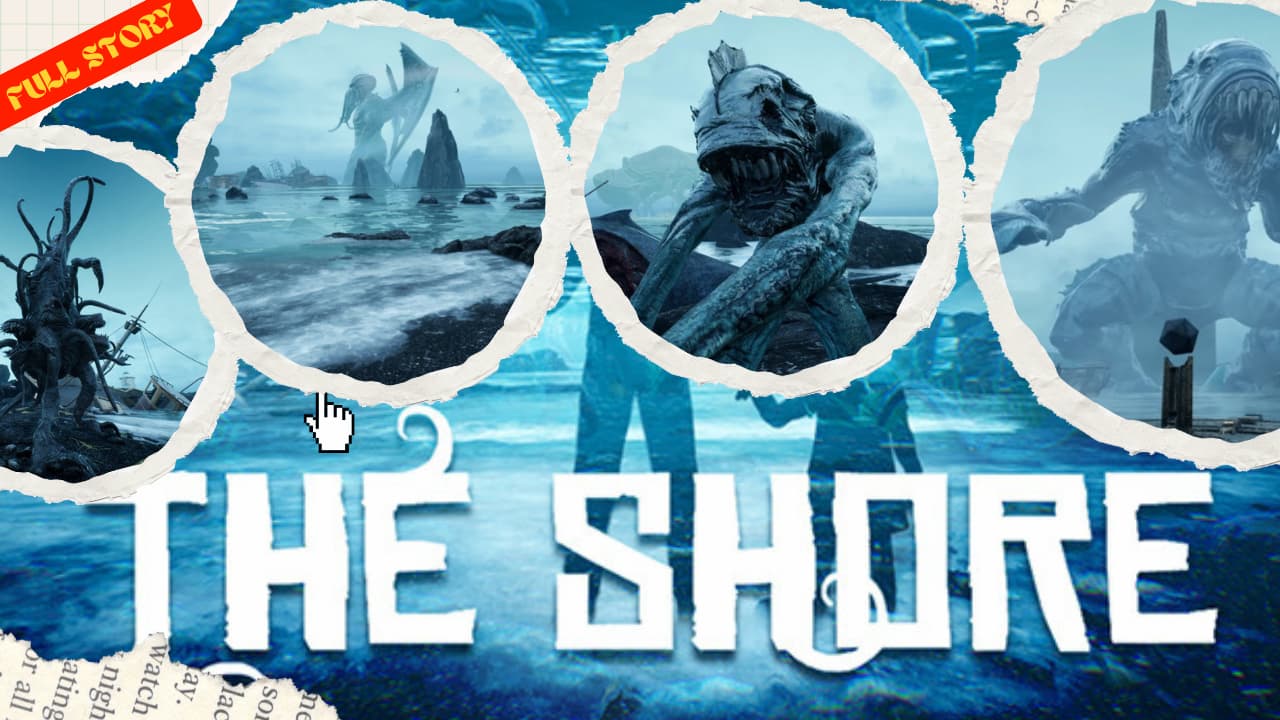





























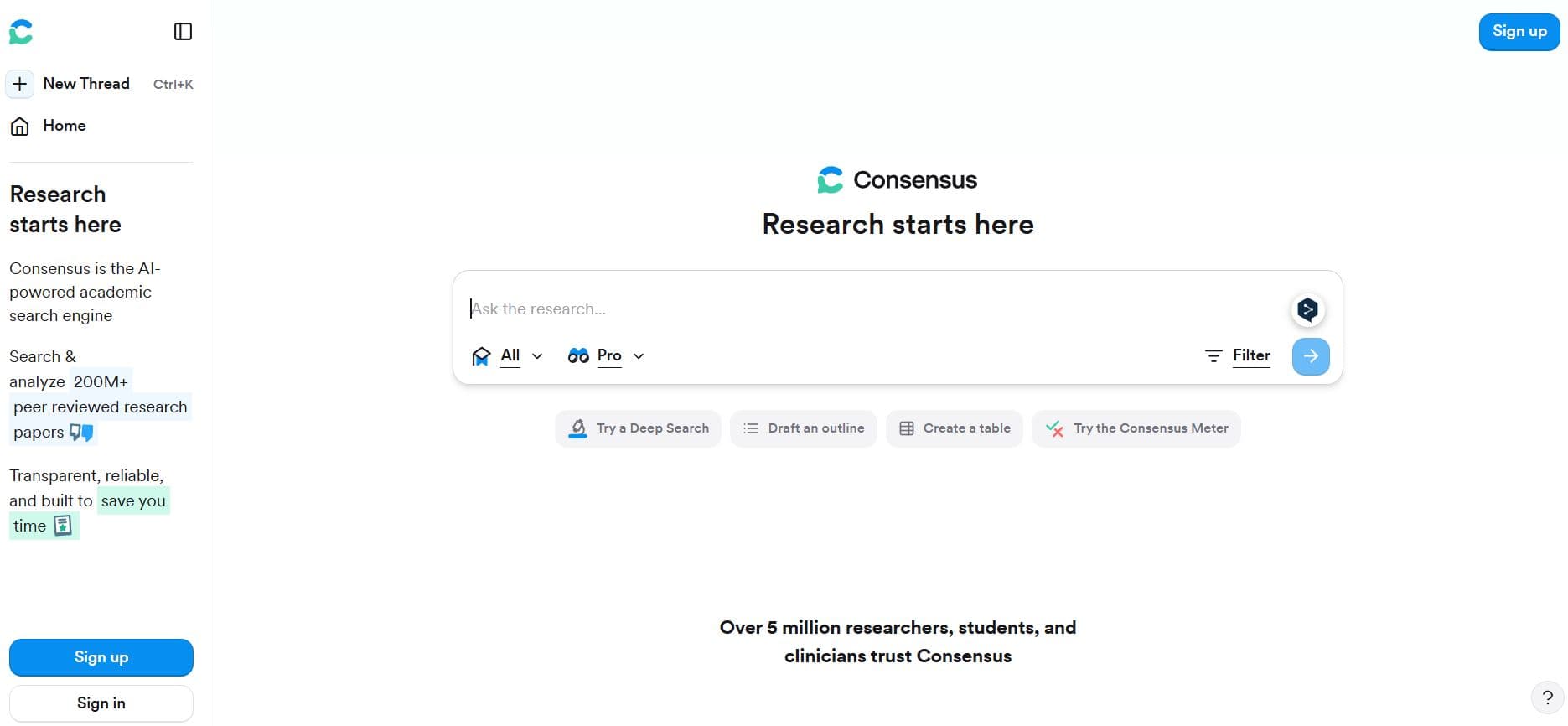

Leave a Reply